|
Storia del Comune di Almè
Il Comune di Almè e' un centro industriale della collina bergamasca, che sorge presso la sponda sinistra del Brembo, in un ampio piano di fronte alle pendici dell'Albenza, all'inbocco della Val Brembana. Dista da Bergamo 8 km e si trova a 294 metri s.l.m..
|
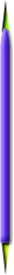 |
|
La vecchia Chiesa
Fu costruita nel secolo XV e venne ampliata nel 1740 e nel 1884. Oggi e' sconsacrata ed e' stata trasformata in un gigantesco ripostiglio nel quale si puo' trovare di tutto. Gli arredi sacri sono stati "trasferiti" nella nuova parrocchiale, la cui prima pietra fu posta il 19 ottobre 1953 (la costruzione fu ultimata nel 1956). Una curiosità: questa nuova chiesa manca della torre campanaria, e le campane che suonano sono quelle della vecchia parrocchiale. Tra i dipinti vi sono un'opera del Ceresa
e una Madonna e Santi attribuita a Palma il Vecchio. Gli stalli del coro hanno fini intagli settecenteschi; tra gli arredi sacri spiccano un notevole
calice d'argento in parte dorato e lavorato a cesello del 1616, e un piviale lavorato in oro. Sulle pareti della chiesa spiccano le scene di una bella
Via Crucis in rame sbalzato. |
Il Borghetto
Poco distante dalla piazza della parrocchiale (dove negli anni '60 e' stato edificato il monumento dei caduti) c'e' il quartiere
del Borghetto. Il quartiere e' anche del "Baluardo" in ricordo delle antiche fortificazioni. Insieme a piazza San Fermo e' l'unico angolo di Almè
che si e' salvato dall'azione demolitrice delle ruspe che, per il resto, hanno cambiato radicalmente la fisionomia del paese. Il sapore e' quello
- anonimo e senza sugo - di grossa periferia cittadina, con una decisa presenza industriale. Le famiglie contadinesono praticamente scomparse:
e pensare che un tempo Almè era un grossissimo centro agricolo e ancora oggi (come negli altri paesi della zona) si possono ammirare notevoli
esempi do case contadine. La caratteristica e' data dal tipo di muro in uso, quello a spina di pesce che - come e' stato sottolineato dagli esperti
- qui "conosce alcuni degli esempi piu' espressivi della terra bergamasca".
Ponte della Regina
Un grosso centro agricolo: quindi, nel passato, un paese ricco. Con Almenno S. Salvatore e S. Bartolomeo, Alme' formava un tempo la citta' di Lemine, sede, nell'ottavo secolo, della regia corte dei Longobardi. Per estensione e numero di abitanti, superava allora la stessa Bergamo. Vanto di Lemine era il Ponte sul Brembo, che portava lo stesso nome (poi detto della Regina) e che fu oggetto, sul finire dello stesso secolo, di approfonditi studi (gli unici) da parte dell'Ingenier Elia Fornoni.
Visibili in questa foto antica, i ruderi del vecchio ponte.
Secondo il Fornoni, la costruzione e' da collocare al tempo dell'Imperatore Traiano, che ne realizzo' uno simile anche ad Alcantara, in Spagna. Il ponte (i cui resti sono stati abbattutti alla fine dell'Ottocento: oggi sono visibili alcuni ruderi) era lungo 180 metri ed era alto 24. La larghezza doveva essere di 6 metri e mezzo. Sette le arcate. Sempre secondo il Fornoni, la pila centrale del ponte (che nella parte emergente - escluse cioe' le fondazioni - era costituita da circa 15 mila metri cubi di muratura, rivestita esternamente da massicci conci in pietra arenaria) doveva sostenere le spalle di un arco trionfale. La rovina comincio' il 31 agosto 1493, quando - durante una piena eccezzionale - caddero quattro archi.
La denominazione popolare di Ponte della Regina ha sempre costituito un rompicapo. Alle varie ipotesi avanzate, tutte attendibili,
vogliamo aggiungere la nostra, forse meno seducente di leggenda ma piu' concreta: e cioe' che la dominazione "Regina" non e' altro che storpiatura dialettale di "Rezia", la regione alpestre alla quale portava l'antica strada romana che passava sul Ponte di Almè. C'e' anche chi ha parlato di Regina, nel senso di "Regina delle costruzioni", meraviglia delle meraviglie, ponte ben degno dell'antica corte, la cui importanza puo' essere valutata
meglio se si pensa alla sua estensione originaria, che comprendeva anche l'attuale Villa d'Almè, Stabello, Bruntino e Zogno (restano, come monumenti, la torre di San Michele e la torre di San Fermo.
Isole d'un tempo
Il paese, s'e' detto, e' molto cambiato. Il contrasto fra
le "Isole d'un tempo", con le case fatte interamente di sassi presi dal
fiume, i muretti di ciottoli, le viuzze strette e senza traffico, i loggiati
in legno con i panni stesi ad asciugare, il contrasto fra tutto questo
ed il nuovo Almè, fatto di villette e di capannoni, e' stridente.
A parziale consolazione, rimane la bellissima Torre campanaria della chiesina
di S. Michele, dalle eleganti finestre bifore, che domina la parte vecchia.
Ma poco piu' in là l'orizzonte e' tutto un susseguirsi di moderni
condomini. San Michele e' di rustica architettura romanica (XI) come il
campanile, tra i piu' antichi e belli di tutta la bergamasca, inferiore
forse soltanto a quelli di San Fermo a Credaro e di Sant'Egidio a Fontanella.
Torre quadrata in pietra arenaria, il campanile e' stato restaurato negli
anni Settanta del nostro secolo, quando ormai minacciava di crollare. Un
restauro che ha lasciato la bocca amara a molti: sono infatti state otturate
alcune belle finestre che, secondo una caratteristica frequente nei campanili
romanici, aveva la funzione di alleggerire la mole. La chiesetta e' divisa
in due vani: in uno di questi vi e' un bell'affresco cinquecentesco, unico
avanzo delle originarie decorazioni. Vi e' pure conservata una statua della
Madonna che viene portata in processione alla festa del paese, che si celebra
l'ultima domenica del mese di settembre anche se San Giovanni, il patrono,
cade a giugno.
Un po' di Medioevo
Tra i resti medioevali che sopravvivono intorno alla chiesa di San Michele, notevole e' la torre di San Fermo sorta, secondo la leggenda, sul luogo del martirio del santo. La costruzione , tozza e massiccia, manca delle originarie strutture superiori che vennero sostituite da un comune tetto quando divenne abitazione. Poco piu' in là, le vecchie case che costeggiano via Campofiori: una volta erano tutte fattorie, ora l'unica nota agreste rimasta e' la polenta alla contadina.
Tratto da: La Bergamasca in Collina edito da Grafica e Arte Bergamo
|
